PROLOGO: Lo Sguardo Attraverso il Tempo
Il tempo è un oblò che gira. A volte avanti, a volte indietro, sempre in movimento. Come quello della vecchia lavatrice di casa, che trasformava il bucato in uno spettacolo magico per gli occhi di un bambino.
La luce filtrava attraverso il vetro rotondo, creando geometrie impossibili nell’acqua saponata. Era il 1970, o forse il ’71 – le date si confondono ma le sensazioni rimangono, precise come fotografie.
“Ancora lì a guardare?” La voce di mia madre, un misto di tenerezza e preoccupazione. “Vieni via, ti fa male agli occhi.”
Ma gli occhi non si ammalavano. Si aprivano, piuttosto. Vedevano possibilità che gli adulti avevano dimenticato di vedere.
Ora, mentre scrivo queste parole, quel bambino e quell’oblò sono diventati una metafora. Di cosa? Di tutto, forse. Del modo in cui guardiamo il mondo, di come scegliamo di vedere – o di non vedere.
L’odore della Farmitalia arrivava a ondate, mescolandosi con il profumo del detersivo. Il mondo era fatto di questi contrasti: il chimico e il domestico, il tecnologico e il naturale, il dentro e il fuori.
“Ma cosa ci vedi di tanto interessante?” chiedevano sempre.
Come spiegare che non era quello che vedevo, ma come lo vedevo? Che l’oblò era una lente attraverso cui il mondo ordinario diventava straordinario?
La lavatrice vibrava leggermente sotto le mie mani. Era calda, viva, come un grande animale meccanico che respirava acqua invece di aria. I vestiti dentro vorticavano in una danza ipnotica, trasformandosi in creature marine, in nuvole colorate, in mondi possibili.
“Vieni via da lì,” dicevano. “Vai a giocare fuori.”
Ma “fuori” era ovunque. L’oblò era il mio modo di guardare, non solo cosa guardavo. Era un modo di essere nel mondo: sempre un po’ di traverso, sempre cercando l’angolo giusto per vedere le cose diversamente.
Il rumore dell’acqua, il ronzio del motore, il clic del timer meccanico – era una sinfonia domestica che accompagnava le mie prime esplorazioni dell’universo. Un universo che iniziava da un vetro rotondo in una cantina di Settimo Torinese, ma che si sarebbe esteso ben oltre, attraverso altri oblò, altri schermi, altri modi di guardare.
Questa è una storia di sguardi. Di come impariamo a vedere – noi stessi, gli altri, il mondo. È una storia di trasformazioni, come il bucato che entra sporco ed esce pulito. È una storia di cicli, come il tamburo che gira e gira, mescolando acqua e memoria, sapone e sogni.
“Un giorno capirai,” dicevano gli adulti.
E avevano ragione, ma non nel modo che pensavano. Perché quello che ho capito è che il bambino davanti all’oblò vedeva qualcosa di vero. Qualcosa che gli adulti avevano dimenticato: che la magia non è negli oggetti straordinari, ma nel modo straordinario di guardare gli oggetti ordinari.
Ora, mentre il cursore lampeggia sullo schermo come una volta lampeggiava la luce nell’oblò, mi preparo a raccontare questa storia. Non è solo la mia storia. È la storia di un modo di vedere. Di un oblò che è diventato finestra, poi porta, poi strada.
È la storia di come ho imparato a guardare il mondo. E di come il mondo, a volte, ha ricambiato lo sguardo.
Hai ragione, scusami – il capitolo 1 originale è nei contenuti che mi hai fornito. Da “Il Tempo del Non Ricordo” nella parte 1. Procedo con la riscrittura del Capitolo 1, integrando e migliorando mantenendo l’autenticità:
CAPITOLO 1: L’Oblò come Portale
La memoria è come acqua nell’oblò: a volte limpida, a volte torbida, sempre in movimento. Alcuni ricordi emergono nitidi come vestiti appena lavati, altri restano sfocati, impigliati nei meccanismi del tempo.
“Tieni questa gallina!” L’urlo di mio fratello risuona ancora, cristallino. La cascina di Volpiano si stendeva intorno a noi come un regno sconosciuto, e io, a tre anni, tremavo davanti a quella creatura che mi sembrava enorme.
“No, no, non voglio!” La mia voce era sottile, impaurita.
“Non fare il bambino! È solo una gallina!”
La gallina mi fissava con occhi arancioni come braci, la testa che scattava avanti e indietro in movimenti meccanici. L’odore del pollaio era intenso, un miscuglio di paglia umida e qualcosa di più selvatico. Mi avvicinai tremante, le mani protese come in una strana danza.
Il dolore del becco fu improvviso, preciso. Le mie urla riempirono il cortile, rimbalzando contro i muri della cascina.
“Mamma! Mammaaaa!”
Oggi non sono sicuro se questo ricordo sia autentico o se sia stato costruito dalle storie familiari, raccontate così tante volte da diventare memoria. Ma la paura di quel momento sembra vera, come un’impronta digitale emotiva che il tempo non ha cancellato.
A cinque anni, il mondo si aprì in modo diverso. “Vieni qui,” disse zia Wilma, prendendomi per mano. Il suo salotto profumava di caffè e biscotti. “Ti faccio vedere una cosa magica.”
La scatola sulla mensola era piccola, decorata con intarsi che sembravano raccontare storie antiche. Quando l’aprì, una musica cristallina riempì l’aria. Una ballerina iniziò la sua danza eterna sopra uno specchio, moltiplicandosi all’infinito nei riflessi.
“È bellissima…” sussurrai, ipnotizzato dal movimento perpetuo.
“Sì,” sorrise zia Wilma, “è speciale, come te.”
Mi sedevo sul pavimento per ore, le gambe incrociate, gli occhi fissi sul carillon. La musica continuava a suonare, e io mi perdevo in quel mondo di specchi e movimento, dove una sola ballerina diventava un’infinita compagnia di danza.
“Perché ti piace tanto guardarlo?” chiese mia madre un giorno, trovandomi ancora rapito dallo spettacolo.
“Perché…” esitai, cercando le parole giuste, “perché qui tutto è possibile. La ballerina non è mai sola, ci sono sempre altre ballerine con lei. Anche quando balla al contrario negli specchi, è comunque bella.”
Mia madre mi accarezzò i capelli, e vidi nei suoi occhi che capiva. Capiva che stavo parlando di più che di un semplice carillon.
I ricordi della cascina emergono come sogni sfocati: l’odore del fieno fresco, il muggito distante delle mucche, il vento che suonava una musica misteriosa tra le travi del tetto. Suoni e profumi che il tempo ha conservato meglio delle immagini.
“Mi racconti ancora di quando vivevamo nella cascina?” chiedevo spesso a mia madre.
“C’era tanto spazio,” rispondeva sempre, “e tu eri così piccolo… correvi ovunque, anche se avevi paura delle galline.”
Oggi, seduto davanti al computer, cerco di afferrare questi primi ricordi. Sono come farfalle che si posano brevemente sulla coscienza prima di riprendere il volo. Non so quali siano reali e quali siano stati costruiti dalle storie familiari, ma so che hanno contribuito a formare chi sono.
“A volte,” dico al mio riflesso nello schermo, “non importa se un ricordo è vero o no. Importa cosa ci ha insegnato.”
La luce del tramonto filtra attraverso la finestra, colorando la stanza di arancione. Fuori, la città si prepara alla notte, tanto diversa dalla cascina di Volpiano. Ma i ricordi danzano ancora, come la ballerina nel carillon, moltiplicandosi all’infinito negli specchi della memoria.
1.bis – Interludio 1: Il Carillon di Zia Wilma
La casa di zia Wilma era un museo di meraviglie. Ogni domenica pomeriggio, mentre i grandi parlavano di cose da grandi in cucina, io mi rifugiavo nel suo salotto. Era una stanza magica, dove il tempo sembrava muoversi a un ritmo diverso.
“Vieni qui,” sussurrò quel pomeriggio particolare. Non disse altro, ma i suoi occhi brillavano di una luce speciale. La seguii fino alla credenza di noce scuro, dove teneva i suoi tesori.
“Oggi ti faccio vedere una cosa,” disse, raggiungendo il ripiano più alto. “Ma devi promettere di guardare con attenzione.”
Ricordo ancora il profumo del legno antico, mischiato all’odore delle sue caramelle alla menta. Era un profumo che sapeva di segreti.
La scatola era piccola, decorata con intarsi che sembravano raccontare storie antiche. Le sue mani, nodose ma gentili, la aprirono con la reverenza che si riserva alle cose sacre.
“Era di mia nonna,” spiegò mentre una musica cristallina riempiva l’aria. “Lei diceva che era magica.”
La ballerina iniziò la sua danza eterna. Era piccola, fragile, dipinta con cura minuziosa. Ma non era questo che la rendeva speciale. Era lo specchio sotto i suoi piedi, che moltiplicava la sua danza all’infinito.
“Guarda,” disse zia Wilma, ruotando leggermente la scatola. “Vedi come cambia?”
Annuii, incapace di parlare. Ogni piccolo movimento creava una nuova coreografia di riflessi. La ballerina non era mai sola – era accompagnata da infinite versioni di sé stessa, ognuna leggermente diversa, ognuna perfetta a modo suo.
Mi chiedevo se anche le persone fossero così: una versione visibile e mille riflessi nascosti.
“Gli altri ridono,” disse zia Wilma dopo un momento, “quando dico che è magica. Dicono che è solo un gioco di specchi.”
“Non è solo quello,” risposi, trovando finalmente la voce. “È come… come se ci mostrasse tutti i modi possibili di essere.”
Mi guardò con quella sua espressione particolare, come se vedesse qualcosa che gli altri non notavano. “Sai una cosa? Mia nonna diceva che questo carillon mostra a ognuno qualcosa di diverso. Che ognuno ci vede quello che ha bisogno di vedere.”
“E tu cosa ci vedi, zia?”
“Io?” Sorrise, un sorriso pieno di segreti. “Ci vedo te, che guardi il mondo in un modo tutto tuo. Come facevo io alla tua età.”
Non capii allora quanto quelle parole fossero importanti. Come ogni specchio del carillon rifletteva una versione diversa della ballerina, così ogni ricordo riflette una versione diversa di noi stessi. E forse è questo il vero regalo che zia Wilma mi fece quel pomeriggio: non il permesso di guardare il carillon, ma il permesso di vedere il mondo in modo diverso.
“Posso guardarlo ancora?” chiesi.
“Tutto il tempo che vuoi,” rispose. “I segreti più importanti hanno bisogno di tempo per essere compresi.”
La musica continuava a suonare, cristallina e antica. La ballerina continuava a danzare nei suoi mille riflessi. E io continuavo a guardare, imparando che la magia non sta nelle cose, ma nel modo in cui scegliamo di vederle.
Anni dopo, quando zia Wilma non c’era più, ho capito che quel carillon era più di un giocattolo prezioso. Era una lezione sulla bellezza della diversità, sull’infinità dei modi possibili di essere se stessi. Era il suo modo di dirmi che andava bene essere diverso, che la vera magia sta nell’essere autenticamente se stessi, in tutti i nostri riflessi.
CAPITOLO 2: Il Mondo dei Sensi
I sensi registrano tutto prima che la mente possa catalogare le esperienze. L’odore della Farmitalia arrivava prima dei pensieri, prima delle parole, prima persino della paura.
Il fetore chimico si insinuava dalle finestre all’alba, svegliandoci prima della sveglia. Un miscuglio dolciastro e nauseante che diventava parte del respiro quotidiano.
“Che puzza oggi,” borbottava mio fratello dal letto accanto.
“È la nuova medicina che stanno facendo,” rispondevo annusando l’aria. “Questa ha un odore diverso dal solito.”
Le sirene della Farmitalia scandivano il ritmo delle nostre giornate. Avevano un loro linguaggio, che imparammo a decifrare come una lingua madre industriale.
“È solo il cambio turno,” diceva mamma dalla cucina quando sobbalzavo. “Non è l’allarme.”
“Come fai a saperlo?”
“L’allarme fa tre suoni lunghi. Questo è un suono solo, per i turnisti.”
Come antropologi involontari, avevamo imparato a leggere i segni della nostra tribù industriale. Ogni odore, ogni suono aveva un significato preciso nel grande rituale quotidiano della fabbrica.
La Torre del 1200 si stagliava accanto alle elementari come una sentinella del tempo, testimone silenzioso di secoli di cambiamenti. Dal suo cortile sospeso, la città assumeva una forma diversa, quasi poetica nonostante il fumo degli stabilimenti.
“Un giorno,” dicevo a voce alta, “vivrò in un posto dove l’aria sa di aria.”
“E dove sarebbe?” rideva mio fratello.
I gatti del cortile si muovevano come fantasmi tra i bidoni dell’immondizia, le loro code come punti interrogativi nell’aria densa di smog. Li osservavo dal balcone, invidiando la loro capacità di esistere con grazia anche in questo paesaggio industriale.
Ogni città ha il suo sapore. Settimo sapeva di chimica e rassegnazione, di sogni soffocati e piccole ribellioni.
La professoressa di scienze ci faceva catalogare gli odori in classe, un esercizio che per noi era naturale come respirare:
“Questo è antibiotico. Quello è il nuovo antidolorifico. Quell’altro… quell’altro è qualcosa di sperimentale.”
I nostri nasi erano diventati precisi come strumenti di laboratorio. Potevamo dire quale reparto della fabbrica stava lavorando solo annusando l’aria del mattino.
“Come fai a sapere sempre che giorno è senza guardare il calendario?” mi chiedevano.
“Studio gli odori. Ogni giorno è diverso. È come… come una specie di calendario, capisci?”
“Sei proprio strano tu.”
“Lo so,” sorridevo. “Ma almeno non mi perdo mai un giorno di scuola.”
La sera, quando le sirene tacevano e gli odori si facevano più tenui, la città mostrava un altro volto. Le luci delle case si accendevano una dopo l’altra, come stelle artificiali in un cielo sempre troppo inquinato per quelle vere.
Non era solo l’aria a essere diversa. Erano i suoni, le texture, i colori. Tutto parlava un linguaggio industriale che avevamo imparato a tradurre senza renderci conto.
Il cortile della scuola era un’oasi di normalità in questo paesaggio chimico. I bambini giocavano, ignari o forse solo abituati all’aria densa che respiravano.
“Non senti che oggi è diverso?” chiedevo ai compagni durante la ricreazione.
“È sempre uguale,” rispondevano loro.
Ma non era vero. Ogni giorno aveva la sua firma olfattiva, la sua particolare miscela di aromi industriali. Come un enorme calendario sensoriale che solo alcuni di noi sapevano leggere.
La sera, dalla finestra della mia camera, guardavo il fumo che usciva dai camini della Farmitalia. Disegnava forme nel cielo, creature fantastiche che duravano solo un istante prima di dissolversi nel buio.
“È come fare poesia,” spiegavo a chi voleva ascoltare. “Solo che invece di usare le parole, la fabbrica usa il fumo e gli odori.”
Non sapevo ancora che questa sensibilità ai dettagli, questa capacità di trovare significato anche negli odori più tossici, mi avrebbe seguito per tutta la vita.
La notte era il momento più strano. Gli odori si facevano più sottili, più misteriosi. Il silenzio era interrotto solo dal ronzio costante dei macchinari in lontananza, una ninna nanna industriale che ci accompagnava nel sonno.
“Si respira meglio quando dormono tutti,” diceva mia madre mentre chiudeva le finestre per la notte.
E aveva ragione. Come se la città stessa tirasse un sospiro di sollievo quando le fabbriche rallentavano il loro ritmo frenetico.
Era un mondo di contrasti acuti: il dolce e il tossico, il naturale e l’artificiale, la vita che si ostinava a fiorire in un ambiente che sembrava progettato per soffocarla.
Ma era il nostro mondo. E in qualche modo, lo avevamo reso poetico.
CAPITOLO 3: La Geografia del Cuore
Le mappe più importanti non sono quelle che troviamo negli atlanti. Sono quelle che disegniamo con i nostri passi, con le nostre paure, con i nostri desideri.
Via Milano si stendeva davanti a me come una promessa pericolosa. Il tratto verso il cimitero era il più difficile, un territorio dove ogni passo doveva essere calcolato.
“Attento alla strada!” L’avvertimento di mia madre mi seguiva come un’eco.
“Prendi il percorso più lungo,” mi aveva ripetuto mille volte.
Ma quel giorno avevo fretta. Il sole era già alto e la scuola non aspetta. La scorciatoia sembrava una tentazione irresistibile.
“Ehi, guardone!” Le voci dei ragazzi più grandi mi raggiunsero come sassate. Mi strinsi nel cappotto, accelerando il passo. Il cuore batteva forte, ma cercavo di mantenere un’apparenza di calma.
Non mostrare paura. La paura è come il sangue nell’acqua per gli squali.
Il passaggio a livello era la prima grande prova quotidiana. Le sbarre si abbassavano con un ritmo ipnotico, il campanello suonava la sua canzone metallica.
“Perfetto,” mormorai tra i denti. “Proprio quello che mi serviva.”
Una donna con le borse della spesa si fermò accanto a me. Il profumo del pane appena sfornato dal suo sacchetto era come una boccata d’aria pulita nel panorama industriale.
“Brutta giornata, eh?”
“Come lo sa?”
“Hai quella faccia. La faccia di chi vorrebbe essere ovunque tranne che qui.”
Il treno passò rombando, una bestia d’acciaio che faceva tremare la terra. Contai i vagoni, un rituale che mi dava un senso di controllo.
“Ventitré,” dissi quando l’ultimo vagone scomparve.
“Anche tu li conti?” chiese la donna sorpresa.
“Sempre. È… è come un rituale.”
“Per tenere sotto controllo la paura?”
La guardai stupito. “Come fa a…”
“Anch’io lo facevo alla tua età. Questo passaggio a livello… mette sempre un po’ d’ansia.”
La latteria era il prossimo punto di riferimento sulla mia mappa personale. Un’oasi di normalità dove il profumo del latte fresco cancellava temporaneamente gli odori della Farmitalia.
“Il solito?” chiese il lattaio.
“Sì, tre bottiglie.”
Mentre riempiva le bottiglie riciclate, osservavo il latte che scendeva, bianco e denso. Era uno dei pochi momenti di pace nella giornata.
“Sa una cosa?” dissi all’improvviso. “Lei è l’unico che non mi chiede mai perché uso la mano sinistra.”
Si fermò un momento, mi guardò. “E perché dovrei? Il latte è buono con entrambe le mani.”
Ci sono persone che diventano punti cardinali nella geografia personale di un bambino. Non per grandi gesti, ma per piccoli momenti di comprensione.
Uscendo dalla latteria, le bottiglie tintinnavano nella borsa come campane in miniatura. Un suono familiare, rassicurante.
“Ehi, tu!”
Mi girai. Era uno dei ragazzi di prima.
“Ti ho visto che ci guardavi.”
“Io… stavo solo passando.”
“Già, come no. Sei sempre qui intorno, che guardi.”
Le bottiglie nella borsa sembravano improvvisamente pesare una tonnellata. Il tintinnio non era più rassicurante, ma accusatorio.
“Lascialo stare,” intervenne una voce. Era la donna del passaggio a livello.
Il ragazzo esitò, poi se ne andò borbottando qualcosa.
“Grazie,” sussurrai.
“Di nulla. Sai, dovresti prendere davvero il percorso più lungo.”
“Lo so. Ma a volte… a volte voglio affrontare le mie paure.”
Mi guardò con un misto di preoccupazione e ammirazione. “Essere coraggiosi non significa essere imprudenti.”
“No,” risposi, “ma significa non lasciare che la paura decida per te.”
Ogni giorno lo stesso percorso, le stesse paure, le stesse piccole vittorie. Era la mia personale Via Crucis, ogni tappa un mistero da affrontare, ogni incontro una lezione da imparare.
Le stagioni cambiavano il paesaggio urbano, ma i punti della mia mappa rimanevano costanti: il passaggio a livello, la latteria, l’edicola dove potevo sfogliare i fumetti fingendo di non esistere.
“Ti vedo sempre passare,” disse un giorno l’edicolante. “Sei come un orologio.”
“È l’unico modo che conosco per attraversare la città.”
“Ci sono altri modi.”
“Lo so. Ma questo è il mio.”
La geografia del cuore non segue le regole della cartografia. È fatta di scorciatoie e deviazioni, di luoghi sicuri e zone proibite, di incontri che diventano riferimenti più precisi di qualsiasi coordinate.
E così, passo dopo passo, paura dopo paura, stavo disegnando la mia mappa personale della città. Una mappa invisibile agli altri, ma più reale di qualsiasi atlante.
3.bis – Interludio 2: La Cascina dei Ricordi
Il cortile della cascina di Volpiano era un universo a sé. Non era come i cortili ordinati della città – era un mondo selvaggio, dove ogni angolo nascondeva una nuova avventura, un nuovo pericolo, una nuova scoperta.
I ricordi di quel periodo sono come fotografie sbiadite, ma gli odori… gli odori sono ancora vividi come il primo giorno.
L’odore del fieno nuovo riempiva l’aria del mattino. Non era il profumo dolce che immaginano i cittadini – era qualcosa di più complesso, un miscuglio di erba tagliata, terra umida e sole.
“Non correre vicino alle balle!” gridava sempre mia madre. “Possono rotolare!”
Ma io correvo lo stesso, perché le balle di fieno erano montagne da scalare, fortezze da conquistare, nascondigli perfetti per i miei giochi solitari.
Non capivo allora che quella libertà di muovermi in uno spazio così vasto era un privilegio. La cascina era il mio primo regno, e io ne ero l’esploratore solitario.
Il pollaio era il territorio nemico. Le galline mi terrorizzavano con i loro movimenti imprevedibili, i loro occhi arancioni, il loro modo di muovere la testa a scatti.
“Devi raccogliere le uova,” diceva mio fratello maggiore. “È facile, guarda.”
“Non voglio,” sussurravo, ma lui insisteva.
“Non fare il bambino! Sono solo galline!”
Ma non erano “solo” galline per me. Erano draghi in miniatura, creature incomprensibili che governavano il loro territorio con becchi affilati e sguardi indecifrabili.
La stalla aveva un’atmosfera completamente diversa. Le mucche erano presenze rassicuranti, con i loro occhi grandi e dolci e il loro modo lento di masticare. Il calore dei loro corpi rendeva l’aria densa, quasi solida.
“Vieni,” mi diceva il vecchio Piero, il mezzadro. “Ti faccio vedere come si munge.”
Mi sedevo su uno sgabello troppo grande, guardando affascinato le sue mani callose che si muovevano con una grazia sorprendente.
“Devi essere gentile,” spiegava. “Gli animali capiscono se hai paura.”
Non gli dissi mai che avevo più paura delle galline che delle mucche. C’era qualcosa di saggio in quegli occhi bovini, una pazienza che le galline non avevano.
La sera era il momento più magico. Il sole calava dietro i campi di grano, tingendo tutto di oro. Il vento portava l’odore della cena che si preparava, mescolato al profumo del letame e del fieno.
“Rientra!” chiamava mamma. “Si sta facendo buio!”
Ma il buio della cascina non era il buio della città. Era un buio vivo, pieno di suoni: il muggito distante delle mucche, il fruscio del vento tra le travi del fienile, il canto dei grilli che sembrava non finire mai.
Ora, ripensando a quei momenti, capisco che la cascina mi ha insegnato qualcosa di fondamentale: che la paura e la meraviglia possono coesistere. Che si può essere terrorizzati dalle galline ma incantati dalle mucche. Che ogni luogo ha il suo ritmo, la sua musica, la sua magia.
Il vecchio pozzo nel cortile era il mio posto preferito. Mi sporgevo per guardare il mio riflesso nell’acqua scura, immaginando che fosse un portale per un altro mondo.
“Non ti sporgere troppo,” diceva sempre nonna. “Il pozzo è profondo.”
“Quanto profondo?” chiedevo.
“Abbastanza da contenere tutti i segreti del mondo,” rispondeva con un sorriso misterioso.
La cascina aveva i suoi rituali. Il risveglio all’alba con il canto del gallo. La mungitura del mattino. Il pranzo sotto il pergolato quando faceva caldo. La processione delle mucche che tornavano dal pascolo al tramonto.
Era un mondo ordinato nel suo disordine, preciso nelle sue imperfezioni. Un mondo che seguiva regole più antiche di quelle della città, più vicine alla natura e ai suoi cicli.
“Perché ti piace tanto stare qui fuori da solo?” mi chiese una volta mia sorella.
“Perché qui,” risposi dopo un momento di riflessione, “anche essere soli non vuol dire essere soli. C’è sempre qualcosa che ti fa compagnia.”
Non era solitudine, era qualcosa di solido. Come il muro della stalla riscaldato dal sole, come l’odore del fieno, come il muggito delle mucche nella nebbia del mattino.
Quando ci trasferimmo in città (cittadina prima e poi vera e propria metropoli), portai con me questi ricordi come talismani. L’odore del fieno, il calore della stalla, la paura delle galline, la magia del pozzo. Erano più di semplici memorie – erano le prime pagine della mia storia, scritte nell’inchiostro indelebile dell’infanzia.
E forse è per questo che, anni dopo, continuavo a cercare quella magia nei luoghi più improbabili: nell’oblò della lavatrice, nelle balle di carta da macero, nel fumo della Farmitalia. Perché la cascina mi aveva insegnato che la magia non sta nei luoghi, ma nel modo in cui li guardiamo.
CAPITOLO 4: Il Regno della Carta
Il sudore ha un odore particolare quando si mescola con la polvere di carta. È l’odore del lavoro di mio padre, l’odore della mia infanzia, l’odore di segreti nascosti tra le pagine.
La leva dell’imballatrice si muoveva su e giù con un ritmo ipnotico. Non era automatica – ogni movimento richiedeva forza, ogni balla era una battaglia personale contro la gravità.
“Piano,” diceva mio fratello. “Devi trovare il ritmo giusto.”
“È pesante,” ansimavo, le braccia che tremavano.
“Lo so. Ma papà non può farlo ora, con l’ernia. Tocca a noi.”
Guardavo la montagna di carta da comprimere, facendo calcoli mentali: “Questo cartone… dovrebbe essere almeno mezzo chilo. Cinquecento lire…”
“Sempre a fare i conti, eh?” rideva mio fratello.
I conti erano il mio modo di dare ordine al caos. Come se trasformare la carta in numeri potesse rendere tutto più comprensibile.
“А это что такое?” [E questo cos’è?] dissi all’improvviso, notando un libro in cirillico tra la carta.
“Parli di nuovo in quella lingua strana?”
“È russo. L’ho imparato dai libri che troviamo qui.”
Mi chinai per raccogliere il libro, ma qualcosa di nero si mosse tra le pagine.
“RAGNO!” urlai, saltando indietro. Il terrore era viscerale, primitivo.
“Il grande studioso di russo ha paura dei ragni!” Mio fratello scoppiò a ridere.
“Non è divertente,” borbottai, ancora tremante. “Sono ovunque in questa dannata carta.”
I ragni erano i custodi involontari dei nostri tesori cartacei. Come bibliotecari a otto zampe che decidevano quali segreti potevamo scoprire.
“Come quando al Mulino…” iniziò mio fratello, ma lo interruppi con un altro urlo.
“AIUTO! Un altro ragno!”
Si voltò di scatto, e ne approfittai per cambiare argomento. Alcuni segreti dovevano rimanere tra le balle di carta.
La leva dell’imballatrice continuava il suo movimento ipnotico. Su e giù, su e giù. Come una preghiera meccanica, un mantra industriale.
“Знаешь,” [Sai,] dissi mentre lavoravamo, “questa carta racconta storie.”
“In russo?”
“In tutte le lingue. Guarda qui…” Mi chinai a raccogliere un foglio. “Questa è una lettera d’amore mai spedita.”
“Come fai a saperlo?”
“‘Mio caro,’” lessi, “‘non ho mai trovato il coraggio di dirti…’ Vedi? È una storia incompiuta.”
Ogni foglio era un frammento di vita, un pezzo di qualcuno che non avrei mai conosciuto ma di cui conservavo un segreto.
Le riviste erano una categoria a parte. Alcune le nascondevo in cima alle balle, dove nessuno guardava mai. Erano il mio tesoro proibito, la mia biblioteca segreta di desideri inespressi.
“Ti ho visto, sai?” disse mio fratello un giorno. “Quando nascondi certe riviste.”
Il sangue mi si gelò nelle vene. “Non sono affari tuoi.”
“Tranquillo. Non dirò niente a papà. Ma dovresti essere più attento.”
La carta aveva un suo linguaggio. Il fruscio delle pagine, il rumore sordo delle balle compresse, il cigolio della pressa – era una lingua che avevo imparato a decodificare prima ancora del russo.
Come un archeologo delle emozioni, scavavo tra gli strati di carta cercando tracce di vite altrui che potessero illuminare la mia.
La sera, le mani sporche d’inchiostro raccontavano la storia della giornata. Nere come quelle di uno scriba antico, ma i geroglifici erano macchie di toner e graffi di carta riciclata.
“A volte,” sussurrai a mio fratello, “penso che questa carta sappia più cose di me di quante ne sappia io stesso.”
Mi guardò con un misto di preoccupazione e affetto. “Sei proprio strano, lo sai?”
“Lo so,” sorrisi. “Ma almeno sono in buona compagnia. Ho tutti questi libri, tutte queste storie…”
“E tutti questi ragni,” aggiunse lui ridendo.
Le balle di carta erano il mio primo archivio di segreti. Prima dei diari, prima dei computer, prima dei tabulati, c’era questo: un universo di carta che custodiva le confessioni degli sconosciuti e le mie.
La giornata continuava così, tra risate e fatica, tra scoperte e paure, tra russo e ragni. L’imballatrice divorava carta e sputava balle compatte, e io continuavo a calcolare: mezzo chilo, mille lire, una nuova parola in russo, un altro segreto da custodire.
Sì, hai ragione. Devo riscrivere il Capitolo 5: La Casa delle Voci focalizzandomi solo sul periodo dell’infanzia dalla parte 1, eliminando le contaminazioni con la parte 2. Ecco la versione corretta:
CAPITOLO 5: La Casa delle Voci
Le case dell’infanzia hanno una memoria propria. Non sono solo muri e stanze, ma contenitori di echi, di profumi, di attese. La nostra era una sinfonia costante di voci e silenzi.
Gli scalini di legno scricchiolavano ognuno in modo diverso, come un xilofono accordato dal tempo. C’era il gradino “lagnoso” a metà scala, quello “canterino” prima dell’ultimo piano.
“Piano sulle scale!” La voce di mamma rimbalzava tra le pareti. “Si svegliano i vicini!”
Ma era impossibile non correre. La vescica piena e il bagno in cortile creavano un’urgenza che nessun rimprovero poteva contenere.
Il bagno in cortile era una delle prime lezioni di umiltà. Non importava il freddo, la pioggia, o la paura del buio – quando dovevi andare, dovevi andare.
I rumori della famiglia si sovrapponevano come strati di una torta sonora. Il russare di papà, il mormorio della radio in cucina, il tintinnio delle stoviglie che mamma lavava.
“Quanti siete in casa?” chiedevano sempre i nuovi vicini.
“Dipende dall’ora,” rispondeva mamma con un sorriso. “C’è chi va, chi viene…”
La cucina era il cuore pulsante della casa. Era lì che le voci si mescolavano al profumo del sugo, al sibilo della caffettiera, al crepitio della radio.
“Abbassa quella radio!” tuonava papà dal suo riposo pomeridiano.
“Ma c’è la canzone di Celentano…” protestava qualcuno.
La radio era la nostra finestra sul mondo. Anche quando non capivamo le parole, la musica ci parlava di possibilità, di vite diverse dalla nostra.
Il tavolo della cucina era il nostro parlamento familiare. Lì si discuteva, si litigava, si faceva pace. Lì i problemi venivano esposti e, qualche volta, risolti.
“Non parlare mentre mangi,” diceva papà.
“Ma quando posso parlare allora?”
“Quando hai finito di masticare.”
Le sere avevano una voce diversa. Più morbida, come se la stanchezza della giornata avesse limato gli spigoli delle parole. Mamma canticchiava mentre riordinava, una nenia veneta che parlava di terre lontane.
“Che canzone è?” chiedevo.
“Una che cantava mia nonna. E sua madre prima di lei.”
Le canzoni sono la memoria delle famiglie. Passano di generazione in generazione come geni musicali, portando con sé storie più antiche delle parole.
La notte era piena di sussurri. I genitori che parlavano oltre la parete sottile, il respiro dei fratelli che dormivano, il ticchettio dell’orologio in cucina.
“Senti anche tu le voci?” chiedevo a mio fratello nel buio.
“Quali voci?”
“Quelle della casa. Come se… come se ci parlasse.”
“Dormi,” rispondeva lui. “Sogni troppo.”
Ma non erano sogni. La casa viveva, respirava, parlava. Ogni scricchiolio era un messaggio, ogni cigolio una storia.
Le case dell’infanzia non muoiono mai. Continuano a parlarci nei sogni, nei ricordi, nelle sensazioni che riaffiorano quando meno ce lo aspettiamo.
5.bis – Interludio 3: Voci nella Notte
Le scale scricchiolavano di notte. Ogni gradino aveva la sua voce, il suo particolare lamento. Sapevo esattamente quali evitare per muovermi come un fantasma nella casa addormentata.
È strano come la notte trasformi i luoghi familiari. Come se il buio aprisse una porta su una versione parallela della realtà, dove tutto è più intenso, più significativo.
“Non riesce a dormire,” sentivo la voce di mamma dalla cucina. “È la terza notte questa settimana.”
“È solo una fase,” rispondeva papà, ma la sua voce tradiva preoccupazione.
Mi sedevo sul gradino più alto, quello che non scricchiolava, e ascoltavo. Le conversazioni notturne degli adulti erano come una radio che trasmetteva i segreti della famiglia.
“Hai visto i suoi quaderni?” continuava mamma. “Scrive tutto macchiato perché è mancino, l’inchiostro sbava tutto.”
“La maestra dice che dovremmo fargli usare la destra…”
“No,” la voce di mamma era ferma. “Non gli faremo questo.”
Le loro voci erano diverse di notte. Più morbide, più vere. Come se il buio permettesse loro di togliersi le maschere che indossavano durante il giorno.
Il bagno in fondo al corridoio era la mia destinazione abituale, la scusa per queste esplorazioni notturne. Ma spesso mi fermavo prima, attratto dalle voci, dai sussurri, dai segreti.
“Si è addormentato con quel libro russo tra le mani,” diceva mia sorella una notte.
“Dove lo trova tutto questo materiale?” chiedeva papà.
“Lo sai dove. Tra la carta da macero.”
Non capivano che ogni libro trovato era come una finestra su un altro mondo. Che le parole in cirillico erano come un codice segreto che solo io potevo decifrare.
La radio in cucina sussurrava musiche notturne. Radio Capodistria, con le sue melodie slave che sembravano venire da un altro pianeta.
“Spegni quella radio,” borbottava papà.
“Gli piace addormentarsi così,” rispondeva mamma. “Dice che lo aiuta a sognare.”
Il ronzio del frigorifero faceva da sottofondo costante, come un basso continuo in una sinfonia domestica. Di tanto in tanto, un tubo dell’acqua gorgogliava nelle viscere della casa.
La casa aveva una sua vita segreta di notte. Come se tutti gli oggetti che durante il giorno stavano immobili e silenziosi si svegliassero per raccontarsi storie.
“A volte mi fa paura,” sentivo mio fratello dire. “Non paura-paura, ma… è come se vedesse cose che noi non vediamo.”
“È sensibile,” rispondeva mamma. “Come lo ero io alla sua età.”
Dal mio gradino privilegiato, ogni conversazione era un pezzo di un puzzle più grande. Un puzzle che parlava di me, ma che io stesso non capivo completamente.
La notte in cui sentii piangere mamma fu la più difficile.
“E se non riuscirà ad adattarsi?” singhiozzava. “Se il mondo sarà troppo duro per lui?”
“È più forte di quanto pensi,” la consolava papà. “Ha un modo tutto suo di affrontare le cose.”
Non sapevo allora che quelle lacrime erano una forma di amore. Che la preoccupazione è il modo in cui i genitori esprimono la paura di non poter proteggere abbastanza i propri figli.
Il ticchettio dell’orologio in cucina scandiva il tempo di queste veglie segrete. Tick-tock, tick-tock, come un metronomo che teneva il tempo delle conversazioni notturne.
“Dovresti essere a letto,” mi sorprese una volta mia sorella maggiore.
“Non riesco a dormire,” mentii.
“O non vuoi dormire?” mi guardò con comprensione. “So che ascolti. Che cerchi di capire.”
Era la prima volta che qualcuno riconosceva apertamente queste mie esplorazioni notturne. Come se mi stesse dando il permesso di essere curioso del mondo degli adulti.
“A volte,” le confessai, “mi sembra che la notte sia più vera del giorno.”
Lei sorrise. “Perché di notte le persone dicono quello che pensano davvero. Ma ricorda: non tutti i segreti che ascolti sono pronti per essere compresi.”
Da quella notte, le mie esplorazioni continuarono, ma con una consapevolezza diversa. Non ero più solo un ascoltatore casuale, ma il custode dei segreti notturni della famiglia.
Forse è per questo che ancora oggi preferisco la notte. Perché mi ricorda quelle ore magiche in cui, seduto su un gradino che non scricchiolava, imparavo a conoscere non solo la mia famiglia, ma anche me stesso, attraverso i sussurri e i segreti che solo il buio sa custodire.
CAPITOLO 6: Linguaggi Nascosti
Le prime lingue che impariamo non sono quelle che ci insegnano a scuola. Sono quelle che scopriamo da soli, nei libri trovati per caso, nei silenzi necessari, nei sogni non confessati.
Il russo entrò nella mia vita attraverso le balle di carta. Vecchi libri con strane lettere che nessuno voleva, ma che per me erano tesori da decifrare.
“Ma come fai a leggerlo?” chiedeva mio fratello, guardando le pagine con sospetto.
“Non lo leggo ancora. Lo studio. Come se fosse un codice segreto.”
La maestra delle elementari non sapeva cosa fare di questo strano bambino che scriveva con la sinistra e passava le ricreazioni a copiare l’alfabeto cirillico.
“Dovresti giocare con gli altri,” suggeriva.
Ma i giochi degli altri bambini sembravano scritti in una lingua che non riuscivo a capire.
I fumetti erano il mio primo vero dizionario di emozioni. Tra le vignette di Alan Ford e del Gruppo TNT trovavo un modo di nominare sensazioni che non sapevo ancora esprimere.
“Perché leggi sempre le stesse storie?” chiedeva mia madre.
“Perché ogni volta dicono qualcosa di diverso.”
L’edicola era diventata il mio santuario. Il proprietario mi lasciava sfogliare i fumetti senza comprare, come se capisse che stavo imparando qualcosa di più importante del prezzo di copertina.
“Tieni,” mi disse un giorno. “È uscito il nuovo Alan Ford.”
“Non ho soldi oggi…”
“Guardalo e poi rimettilo a posto. So che lo fai sempre con cura.”
I perdenti del Gruppo TNT parlavano la mia lingua. Erano diversi, erano sfigati, erano meravigliosi nella loro imperfezione.
La biblioteca comunale divenne il mio secondo rifugio. Lì potevo esplorare mondi diversi senza dover rendere conto a nessuno.
“Questi sono libri per grandi,” diceva la bibliotecaria, ma mi lasciava leggerli lo stesso.
I libri in russo erano i più preziosi. Li studiavo di nascosto, copiando pazientemente ogni lettera, cercando di capire il significato nascosto dietro quei segni misteriosi.
“А это что такое?” [E questo cos’è?] era diventata la mia frase preferita, anche se non sapevo ancora pronunciarla correttamente.
Era come avere un superpotere segreto: vedere significati dove gli altri vedevano solo scarabocchi incomprensibili.
La sera, nel letto, mescolavo tutte queste lingue in sussurri silenziosi. Parole russe si intrecciavano con citazioni dei fumetti, creando un linguaggio personale che solo io potevo capire.
“Con chi parli?” chiedeva mio fratello dal letto accanto.
“Con nessuno. Sto solo… pensando ad alta voce.”
La scrittura divenne il mio primo vero atto di ribellione. Scrivevo con la sinistra, nonostante i tentativi di “correggermi”. Era più di una preferenza: era una dichiarazione di identità.
“Ma perché non provi con la destra?” insistevano.
“Perché non è la mia mano,” rispondevo semplicemente.
Ogni lingua ha il suo alfabeto, ogni identità ha il suo modo di esprimersi. La mia iniziava dalla mano “sbagliata”.
I diari segreti si moltiplicavano. Non erano veri diari – erano collages di parole russe mezze indovinate, di vignette ricopiate, di pensieri codificati in linguaggi inventati.
“Cosa scrivi sempre?” chiedeva mia sorella.
“Storie.”
“Di cosa?”
“Di mondi diversi.”
La TV parlava un’altra lingua ancora. Calimero, il pulcino nero incompreso, sembrava raccontare la mia storia in bianco e nero.
“È un’ingiustizia, però!” ripetevo con lui, trovando in quella frase un mantra personale.
Ogni diversità cerca il suo linguaggio. Ogni differenza ha bisogno di parole nuove per raccontarsi.
CAPITOLO 7: Mondi Paralleli
L’immaginazione è il primo atto di resistenza. Quando la realtà sembra troppo stretta, troppo rigida, è nei mondi paralleli che troviamo lo spazio per respirare.
La Valle delle Farfalle esisteva solo nella mia testa, ma era più reale di molti luoghi veri. Era fatta di balle di carta che diventavano montagne, di vecchi bidoni trasformati in navicelle spaziali, di ombre che nascondevano portali per dimensioni parallele.
“Chi parla da solo è matto,” gridò un ragazzino passando nel cortile.
“Non sto parlando da solo,” risposi. “Sto creando.”
“Creando cosa?”
“Un universo. Vuoi vedere?”
Si fermò, incurioso. Gli mostrai le montagne di carta, il portale dimensionale, la navicella spaziale.
“Ma è solo spazzatura,” disse.
“No, è quello che ci vedi dentro che conta. Guarda meglio…”
La spazzatura era solo spazzatura finché non le davi un significato nuovo, una storia da raccontare.
La televisione era un altro portale. Non per i programmi – quelli erano prevedibili, controllati – ma per quello che succedeva negli intervalli, quando lo schermo mostrava il monoscopio.
“Non c’è più niente da vedere,” diceva mio fratello quando finivano i programmi.
“C’è sempre qualcosa da vedere,” rispondevo. “Anche nel nulla.”
Il monoscopio diventava una mappa di territori inesplorati, le sue linee geometriche tracciavano percorsi verso mondi possibili.
La radio di notte era diversa. Le voci che ne uscivano popolavano la mia solitudine con presenze amiche. Radio Luxemburg parlava una lingua fatta di musica e sogni.
“Che musica è?” chiedeva mia madre, trovandomi con l’orecchio incollato alla radio.
“Non lo so. Ma mi fa sentire… diverso. Come se ci fosse un altro mondo là fuori.”
Nel cortile, avevo creato una geografia personale. Ogni angolo aveva un nome, una storia, una funzione nel grande gioco dell’immaginazione.
“Là,” indicai un angolo particolare a un nuovo amico, “c’è l’ingresso del castello delle cento stanze.”
“Non vedo nessun castello.”
“Chiudi gli occhi,” suggerii. “Ora immagina una porta enorme, di legno antico…”
“Con i chiodi di ferro?” chiese, gli occhi ancora chiusi.
“Esattamente! E quando si apre…”
L’immaginazione è contagiosa. Una volta che impari a vedere oltre la superficie, è impossibile tornare indietro.
I fumetti non erano solo storie da leggere – erano mappe per mondi alternativi. L’Uomo Ragno non si arrampicava sui grattacieli di New York, ma sui palazzi grigi di Settimo Torinese.
“Perché disegni sempre ragnatele sui tuoi quaderni?” chiedeva la maestra.
“Perché sono vie di fuga.”
Le sere in famiglia avevano una dimensione parallela tutta loro. Mentre gli adulti guardavano Carosello, io vedevo messaggi segreti, codici nascosti, storie dentro le storie.
“Dopo Carosello tutti a nanna!”
Ma nel letto, al buio, i mondi paralleli diventavano più vividi. Il soffitto era un cielo alieno, le ombre sulla parete erano creature misteriose, il ticchettio dell’orologio era il codice morse di un altro universo.
“Dormi?” sussurrava mio fratello dal suo letto.
“No. Sto esplorando.”
“Cosa?”
“La stanza cinquantuno del castello. Quella con gli specchi magici.”
Ogni stanza del castello immaginario era un rifugio, un laboratorio, una possibilità. Era il posto dove potevo essere tutte le versioni di me stesso.
“Raccontami della stanza dei sogni,” chiedeva spesso mio fratello nelle notti insonni.
E così inventavamo insieme, costruendo mondi su mondi, storie su storie, finché il sonno non ci coglieva tra una stanza immaginaria e l’altra.
La realtà aveva i suoi spazi, certo: la scuola, la chiesa, i luoghi del dovere. Ma era negli interstizi, negli spazi tra una cosa e l’altra, che la vera vita accadeva.
“A volte mi preoccupi,” disse un giorno mia madre. “Vivi troppo nella tua testa.”
“Non è nella mia testa,” risposi. “È ovunque. Solo che non tutti lo vedono.”
I mondi paralleli non erano fughe dalla realtà – erano espansioni, possibilità, prove generali di esistenze diverse.
7.bis – Interludio 4: Lo Sguardo Attraverso il Fumo
I camini della Farmitalia erano come matite giganti che disegnavano sul cielo. Il fumo bianco tracciava forme che solo io sembravo vedere: draghi, castelli, storie intere che si dissolvevano nel vento.
Ogni industria ha il suo respiro, la sua voce, il suo odore. La Farmitalia era la nostra aragosta gigante, il mostro marino che dominava l’orizzonte di Settimo. Ma anche i mostri, se li guardi abbastanza a lungo, possono diventare familiari.
“Che puzza oggi,” si lamentava mia sorella aprendo la finestra.
“No, aspetta!” la fermavo. “Questo è diverso. È il nuovo antibiotico che stanno facendo. Ha un odore… quasi dolce.”
“Dolce? Ma sei matto?”
Non era facile spiegare come avessi imparato a distinguere gli odori, a catalogarli, a trasformarli in una specie di calendario olfattivo personale.
La sirena delle sei del mattino era la sveglia di tutto il quartiere. Tre suoni lunghi, come un gigante che si stiracchia.
“Come fai a non spaventarti?” mi chiedeva Marco, il mio compagno di banco.
“Perché so che è amica,” rispondevo. “È il suo modo di dire buongiorno.”
Dal cortile della scuola, guardavamo il fumo che usciva dai camini. Disegnava forme nel cielo azzurro, come nuvole che si potevano comandare.
“Guarda!” indicavo eccitato. “Quel fumo là sembra proprio un drago!”
“È solo inquinamento,” rispondeva la maestra con disapprovazione.
Ma non era “solo” qualcosa. Niente è mai “solo” qualcosa quando hai imparato a guardare il mondo attraverso l’oblò delle meraviglie.
Le sirene parlavano una lingua tutta loro. C’era quella del cambio turno, quella della pausa pranzo, quella dell’emergenza. Ognuna con il suo significato, il suo ritmo, la sua storia.
“Questa è la sirena triste,” spiegavo a mio fratello. “Suona così perché è stanca dopo il turno di notte.”
“Le sirene non possono essere tristi,” rideva lui.
“Tutto può essere triste. Anche le macchine. Anche il fumo.”
La notte era diversa. Il mostro si trasformava in una costellazione di luci, rosse e bianche, che pulsavano come stelle artificiali.
“Sembra quasi bello,” ammetteva mamma, guardando dalla finestra della cucina.
“È sempre bello,” rispondevo. “Solo che di notte non deve fingere di essere qualcos’altro.”
Come me, pensavo ma non dicevo. Come me che di notte potevo essere me stesso, senza dover fingere di essere come gli altri volevano che fossi.
Gli odori avevano un loro ritmo settimanale. Lunedì era l’odore acre degli antibiotici, martedì il dolciastro degli sciroppi, mercoledì…
“Ma davvero riesci a distinguerli?” chiese un giorno il bidello, trovandomi che annusavo l’aria nel cortile della scuola.
“È come una musica,” tentai di spiegare. “Ogni odore è una nota diversa. Insieme fanno una sinfonia.”
“Una sinfonia puzzolente,” rise lui, ma non c’era cattiveria nella sua voce.
I giorni di pioggia erano i più interessanti. Il fumo si mescolava con la nebbia, creando forme ancora più fantastiche.
“Oggi il mostro ha messo il pigiama di nuvole,” dicevo a chi voleva ascoltare.
Era il mio modo di addomesticare la paura. Di trasformare qualcosa di minaccioso in qualcosa di familiare, quasi amico.
“Quando sarò grande,” annunciai una sera a cena, “voglio sapere cosa c’è dentro quei camini.”
“Veleno,” disse papà cupamente.
“Medicina,” corresse mamma.
“Storie,” pensai io. “Storie che aspettano di essere raccontate.”
La Farmitalia era più di una fabbrica. Era il nostro orologio, il nostro calendario, il nostro meteo. Le sue sirene scandivano il ritmo delle nostre giornate, i suoi odori marcavano il passaggio delle stagioni.
Anni dopo, quando qualcuno mi chiedeva di Settimo, non parlavo mai della Farmitalia come di un’industria. La descrivevo come un drago addormentato, un gigante gentile, un narratore di storie di fumo. Perché è così che l’avevo vista attraverso gli occhi del bambino che ero.
“Sei proprio strano,” mi dicevano spesso. “Vedi poesia dove c’è solo industria.”
Ma forse è proprio questo il segreto: vedere la bellezza dove gli altri vedono solo il grigio, trovare la magia nell’ordinario, trasformare il mostro in amico. Non è questione di negare la realtà, ma di guardarla con occhi diversi.
E il fumo continuava a disegnare storie nel cielo di Settimo, storie che solo alcuni sapevano leggere.
CAPITOLO 8: Le Prime Trasformazioni
Il cambiamento arriva come la nebbia della pianura padana: prima sottile, poi sempre più densa, fino a che il paesaggio familiare diventa irriconoscibile.
Lo specchio del cortile – quello vicino al rubinetto dove ci si lavava d’estate – fu il primo a mostrarmi i segni del cambiamento. Non era più il bambino di sempre che mi guardava, ma qualcosa di intermedio, indefinito.
“Ti stai allungando,” disse mia sorella, notando come i pantaloni erano diventati improvvisamente troppo corti.
“Come un germoglio storto,” rideva mio fratello.
Il corpo è il primo a tradire l’infanzia: si allunga nei modi più imprevisti, sviluppa angoli dove prima c’erano curve, curve dove prima c’erano angoli.
La voce fu la seconda a cambiare. Non più il tono acuto e sicuro del bambino, ma qualcosa di instabile, che oscillava tra acuti imbarazzanti e bassi improvvisi.
“Stai mutando la voce,” ridevano in famiglia.
“Come un gatto che sta annegando,” aggiungeva immancabilmente mio fratello.
L’oblò della lavatrice continuava a girare, ma le storie che vedevo nel bucato erano diverse ora. Non più avventure di pirati e cowboy, ma qualcosa di più confuso, più inquietante.
“Non stai più ore a guardare il bucato,” notò mia madre.
“Vedo cose diverse ora.”
“Quali cose?”
“Non lo so ancora.”
I libri trovati tra la carta da macero parlavano un linguaggio nuovo. Non cercavo più solo avventure e storie di eroi, ma qualcosa di più profondo, più personale.
Le balle di carta nel cortile non erano più montagne da scalare, ma nascondigli per segreti sempre più pesanti. I fumetti che trovavo raccontavano storie che risuonavano in modo diverso.
“Cosa leggi sempre?” chiese un giorno mio fratello.
“Storie,” risposi vagamente. “Di persone che cercano di capire chi sono.”
Il castello delle cento stanze – il nostro gioco preferito prima di dormire – si era trasformato anche lui. Le stanze che inventavo ora erano più oscure, più misteriose.
“Raccontami della stanza nuova,” chiedeva mio fratello la sera.
“È la stanza degli specchi invisibili,” rispondevo. “Dove ti vedi come sarai, ma non puoi ancora capire l’immagine.”
La verità è che nemmeno io capivo l’immagine. Era tutto sfocato, come guardare attraverso il vetro appannato dell’oblò.
Il russo diventò più di un gioco. Era un codice segreto per pensieri che non sapevo ancora esprimere in italiano.
“Я меняюсь,” [Sto cambiando,] sussurravo alla notte.
La notte stessa era diversa. Non più il buio amico dell’infanzia, ma uno spazio denso di possibilità e paure nuove. I sogni erano cambiati: più vividi, più urgenti.
“Dormi male?” chiedeva mamma, notando le occhiaie.
“Sogno troppo,” rispondevo.
L’ultimo giorno dell’infanzia non ha una data nel calendario. È come l’ultima goccia di rugiada prima che il sole la asciughi: sai che c’era, ma non puoi dire esattamente quando è svanita.
“Sei diverso,” disse un giorno la maestra delle elementari, incontrandomi nel cortile.
“Lo spero,” risposi, sorprendendomi della mia stessa voce.
La trasformazione non ha un punto finale. È solo l’inizio di un viaggio che durerà tutta la vita. Ma questi primi cambiamenti sono i più profondi, perché segnano il momento in cui iniziamo a vedere noi stessi come stranieri.
“Un giorno capirai,” dicevano sempre gli adulti.
E forse avevano ragione, ma non nel modo che pensavano. Perché capire non significava trovare risposte, ma imparare a fare le domande giuste.
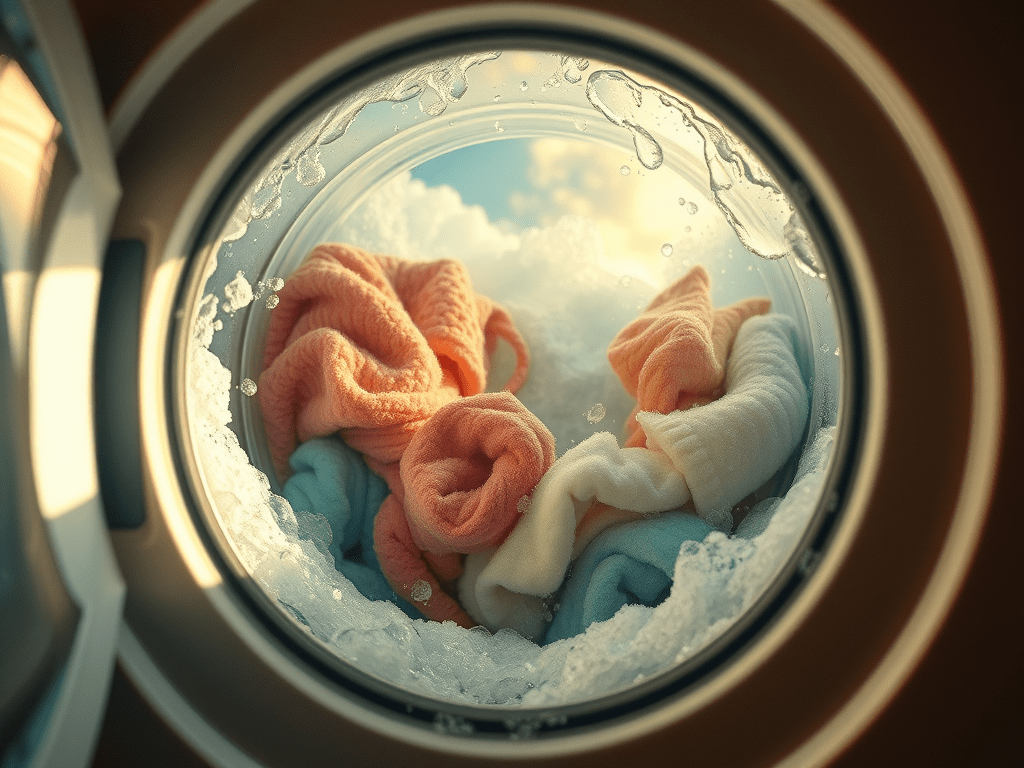
Leave a reply to Salahzar Stenvaag Cancel reply